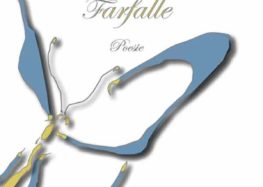PerturbAzioni: Antonio Errico, il cesellatore delle parole
Ci ha abituati a viaggiare verso finibusterrae, all’insegna della luce e dei silenzi di un Salento nascosto e presente, ci ha condotti verso vicoli, boschi, fatti viaggiare con fuggiaschi, riflettere insieme a grandi sovrani, in un vortice che scende in profondità, che trascina senza sosta, parola dopo parola, a scandire luoghi dell’anima: Antonio Errico, classe ’59, un cesellatore di parole.
Lo conosciamo come narratore, già insegnante e attualmente dirigente scolastico del Liceo Socio-Pedagogico di Maglie “Aldo Moro”, inizia la sua passione di “raccontatore” tra le colonne di importanti riviste letterarie contemporanee salentine e continua ancora oggi su alcune di esse come “L’immaginazione” e sul “Nuovo Quotidiano di Puglia”.
Abbiamo ripercorso brevemente il districarsi di questa passione in una lunga intervista, nata come appendice ad una tesi di laurea, che vogliamo pubblicare per condividere insieme a voi lettori.
D.- La Sua attività letteraria ha avuto inizio all’interno delle riviste, a cavallo tra gli anni Settanta ed Ottanta. Cosa L’ha spinta verso quell’impegno e soprattutto, come è entrato a farne parte?
R.-Durante gli anni dell’università maturarono due esperienze importanti: la collaborazione con “ Quotidiano” e l’amicizia con alcune persone che avevano i miei stessi interessi di scrittura.
In quegli anni credo che siano state le riviste a trasformare la fisionomia del fare letterario nel Salento. Soprattutto “Pensionante de’Saraceni” e “ L’immaginazione”. Ho sempre pensato che senza quelle due riviste niente oggi nel Salento sarebbe com’è.
Fra la fine degli anni Settanta e i primi degli Ottanta, cominciai a frequentare amici di scrittura. Molti. Quello che ha avuto un’importanza fondamentale a livello umano e letterario è stato Antonio Verri. Per sintetizzare quello che ha significato, sono costretto all’autocitazione, che è una brutta cosa. Nella dedica ad un racconto apparso su Sud Puglia – Il generale Turno- scrivevo: “ dedico questo racconto a mio padre e ad Antonio Verri. Da mio padre ho imparato a vivere la vita. Da Antonio Verri a vivere la scrittura. Se poi ho fatto confusione è colpa mia”.
Verri era il maestro, l’amico fraterno, il fratello maggiore. Era del 49, dieci anni più grande di me. Era più alto di me. Quando si discuteva e spesso si litigava per come fare questo o quel numero di Pensionante de’ Saraceni, per esempio, o del Quotidiano dei poeti, lui a un certo punto se ne usciva dicendo che dovevo starmi zitto perché lui era più grande e più alto.
Ma tanto per me quanto per lui è stata, come dire?, sentimentalmente essenziale la presenza di Vittore Fiore. Quando ci incontravamo qui o a Bari, io avevo l’impressione di parlare con la Storia.
Una volta lo accompagnai in macchina da Castro a Lecce, perché doveva prendere il treno per Bari. Lui parlava. Parlava. Come se recitasse versi epici con accento barese. Siccome per farlo parlare io andavo piano, perdette il treno. Aspettammo due ore in stazione, seduti alla fine del marciapiedi del primo binario. Lui raccontava.
D.- Soprattutto nel corso degli anni Ottanta, ha collaborato con diverse riviste le cui caratteristiche sono differenti tra loro. Qual è quella che giudicherebbe più affine alla sua scrittura e perchè?
R.- Ne cito solo due, anche se attribuisco un’importanza a tutte: “Pensionante de’ Saraceni” e “ Sud Puglia”, poi “ Apulia”. Con questa rivista ho collaborato per venticinque anni, dall’Ottantasei all’ultimo numero del 2011, escluso dal settembre ‘93 all’agosto ‘94, l’anno in cui ho lavorato in provincia di Milano, la novità e l’impegno che comportava la direzione di una scuola non mi permettevano di scrivere neanche una riga.
Mi chiamò a collaborare il suo grande direttore, Aldo Bello. Aveva letto qualche pezzo mio da qualche parte e mi chiamò. Ci incontrammo in piazza S. Oronzo, al Caffè Alvino. Voleva dei racconti. Il mio primo libro, le Favolerie, nacque dalla raccolta di quei racconti.
Con Aldo Bello c’è stato per venticinque anni un bellissimo rapporto di amicizia, fraterno.
Quando gli amici se ne vanno ti senti terribilmente solo.
Poi vorrei ricordare quell’avventura favolosa che fu “Quotidiano dei Poeti”:
Uscì per tredici giorni, distribuito nelle città italiane più importanti. Non sembrava vero allora; non sembra vero ora.
Tredici giorni di fila: dal 17 al 30 di maggio del novantuno.
D.- Esiste un pezzo giornalistico al quale è legato in modo particolare? Ci spieghi il motivo o ce lo faccia leggere.
R.- A volte qualcuno continua a dirmi che della scrittura sui giornali non resta niente. Alla mattina alle 10 un quotidiano è già passato. Forse è vero, ma questo è bello. E’ appunto una straordinaria metafora della scrittura. Ho il ricordo di un’immagine che mi piace molto. Porta Napoli. Piove. E’ mattina. Per terra un foglio di giornale. Lo guardo. C’è un pezzo mio. L’acqua scorre sul mio nome. La pioggia che scorre sulla scrittura e sul suo autore e si porta via scrittura e autore è un’immagine che mi piace.
Poi, credo che un libro sia una cosa per pochi, un giornale per molti. Per strada, al barbiere, la gente parla con te per quello che hai scritto il giorno prima, quel giorno stesso, sul giornale. Non per i libri.
C’era al mio paese un signore. E’ morto qualche anno fa, molto vecchio. Ogni volta che mi vedeva mi diceva che io come scrittore non valevo niente perché non avevo scritto un libro sulla squadra del mio paese (che militava credo in terza categoria). Mi diceva: tu non avrai mai successo se non scrivi un libro sulla nostra squadra.
Devo dire che sono sempre stato attratto dal senso che alla scrittura e allo scrittore attribuisce nei suoi romanzi Luigi Malerba, uno dei più grandi scrittori del Novecento, di cui mi onoro di essere stato amico.
Allora, sto divagando forse perché non so che dire. Però cerco di spiegare il rapporto che ho con i pezzi sui giornali. Per esempio: non sono mai riuscito a rileggere un libro che ho scritto, ma un pezzo sul giornale me lo rileggo anche due volte. Forse sono affettivamente legato a certe recensioni fatte agli amici. Mi ricordo che quando uscì la recensione alla Betissa di Antonio Verri, lui il pomeriggio arrivò a casa mia portandomi una cassetta di patate. Ricordo l’attacco di quando morì Salvatore Toma, che faceva così: “Si dice in giro che Salvatore Toma è morto. Non ci credete. E’ falso”. Anche se poi argomentavo che sono i poeti che non muoiono mai, la cosa creò un po’ di scompiglio.
Se poi vuole le confesso una cosa: gli articoli mi piacciono quasi tutti. Ma non lo dica a nessuno.
D.- Ha raccontato che il suo primo romanzo Le Favolerie è stato pubblicato, in un primo momento, in puntate sull’allora “Sud Puglia” poi “Apulia” di Aldo Bello, solo successivamente pubblicato da Manni sotto forma di libro.
Come avviene il passaggio, seppur non di cesura, da giornalista a scrittore, cos’è che la porta verso la narrativa?
R.- Un pezzo di giornale lo scrivi per dire qualcosa agli altri. Un romanzo lo scrivi per dire qualcosa a te stesso. Per me è questa la differenza. Di conseguenza non riesco a capire quelli che prima di mettersi a scrivere un romanzo, un racconto, pensano al pubblico, al mercato. Così come mi fanno un po’ ridere quelli che pensano di scrivere per i posteri. Mah. Io credo che si scriva per gli antenati. Per tentare di raccontare le storie che loro non sono riusciti o non hanno potuto raccontare. Forse anche per giustificare il nostro essere qui e ora. Ho scritto i libri soltanto quando ho sentito di farlo. Anzi: quando non ho potuto farne a meno, perché la storia mi girava e rigirava nella testa. Li ho scritti per togliermi quelle storie dalla testa. Ci sono state situazioni in cui certi personaggi non li sopportavo. Certi personaggi di Stralune , per esempio, non li sopportavo. Federico in certi momenti l’ho amato e in altri l’ho odiato. L’ho odiato le volte in cui mi accorgevo che aveva su di me un potere enorme. Diceva quello che voleva lui. Mi emarginava. Mi trattava come il suo segretario al quale dettava delle lettere. Mi ha tenuto sveglio fino alle quattro di notte nei mesi di luglio e agosto. Un tiranno. Mi urlava in faccia che dovevo finire di raccontare il suo ultimo giorno prima che arrivasse settembre e cominciasse la scuola. Sapeva che a quel punto lo avrei trascurato.
Ho chiuso alla fine di agosto. Per una settimana l’ho riletto. Ho chiuso con lui definitivamente la sera del sette di settembre, mentre passava la processione delle Madonna delle Grazie, che è la patrona del mio paese. E’ un’immagine che mi piace ricordare. Poi l’ho dato subito a Manni. Non lo volevo più vedere.
L’esiliato dei Pazzi invece è stato un buon amico, umile e colto, con il quale mi ha fatto molto piacere passare quasi tre anni. Anche con certi personaggi delle Favolerie sono rimasto in ottimi rapporti. Per esempio con Elissa – la Didone fenicia- o con il Copista. Forse il Copista è riuscito a comprendere perfettamente il mio sentimento nei confronti della scrittura.
D.- Nei suoi lavori coesistono alcune caratteristiche, quali il tempo ed il suo trascorrere, la luce a volte fioca ed impercettibile, altre abbagliante, l’essere radicato saldamente alla propria terra sia essa finibusterrae, la Firenze medicea o la Sicilia di Federico di Svevia.
Qual è il legame letterario che La porta a non trascurarne mai alcuno?
R.- Sono convinto che certe risposte siano competenza dei critici. Io ho un grande rispetto dei critici: di quelli onesti. Chi scrive è un pessimo critico di se stesso. Chi scrive qualcosa non dovrebbe mai parlare. Se il testo parla da sé è un buon testo, se non parla vuol dire che è un fallimento. Dai critici ho sempre imparato molto. Però anche in questo caso cercherò di rispondere.
Dunque: mi pare che nel mio modo di narrare ci sia un procedimento non lineare, ma a spirale. Cioè, intenzionalmente, parto da un elemento, atmosfera, suggestione, emozione, sentimento, e cerco di andarci in fondo, di sprofondare. Mentre sprofondo incontro motivi che mi appartengono e me li porto nella scrittura fin quando non li ho messi in parole. Uno di questi motivi è il tempo. Federico, l’Esiliato, tutti i personaggi di Stralune fanno il conto con il tempo: soprattutto il passato, perché è da lì che proveniamo, perché sono convinto che noi siamo fatti di passato. Potrei esibire maleducatamente delle citazioni che vanno da Agostino a Proust, da Ricoeur a Eduardo De Filippo, a Shakespeare.
Confesso anche che non sono un narratore tra virgolette innocente. La passione che per una decina d’anni ho avuto per un pò di filologia, di narratologia, di linguistica, mi permette di, come dire? sorvegliare il testo, di “leggermi” in modo critico, senza comunque rinunciare alla autenticità della scrittura. Alcuni dei miei personaggi sono molto spesso deliranti. E quando fai delirare qualcuno, devi abbandonarti al delirio. Poi rileggi e riscrivi e riscrivi cercando di dare una coerenza perfino al delirio. Mi permetto di dire che bisogna riscrivere molto, asciugare la frase, essenzializzare il lessico.
Certo, esistono legami letterari che però si impastano con quelli esistenziali. La letteratura deve farsi esistenza e l’esistenza letteratura. Mi permetto ancora: se la letteratura non si fa esistenza è un inutile artificio.
Lei dice: tempo, luce, attaccamento alla terra. Ma questi sono motivi dell’esistenza. Qualcuno li dipinge, qualcuno li scrive. Qualcun altro – più saggio – se li tiene dentro per sé soltanto.
Però posso dire una cosa? A me piace molto un’affermazione di Roland Barthes (ecco, un autore che ho amato molto) che dice che lo scrittore non esiste. Esiste solo il testo.
Sulla copertina di un libro ci dovrebbe essere soltanto il titolo senza il nome. Anzi, neanche il titolo, che spesso depista o indirizza. Niente. Un libro dovrebbe essere fatto di fogli anonimi e in edizioni libere. In questo modo si vedrebbe se conta più il marketing o la qualità della scrittura. Se fossi editore farei concorsi pubblici, separando le buste con il testo da quelle con il nome dell’autore. Pochissimi di quelli che adesso vendono un mare di copie supererebbero il concorso, secondo me.
D.- I protagonisti dei suoi romanzi siano essi fuggiaschi, esiliati o tornati alla propria terra, sono legati da un filo rosso: la solitudine.
Sono tutti avvolti da un velo di mistero, che talvolta li rende ambigui, altre enigmatici.
Quali sono, se ce ne sono, le influenze o semplicemente i gusti letterari che La conducono verso il filone narrativo su cui procedere?
R.- Pensando alla risposta da dare a questa domanda mi sono accorto che è vero: si tratta di personaggi estremamente soli. Però non saprei dire se ci sono dei gusti letterari o se si tratta di un filone narrativo. Probabilmente, e semplicemente, le storie che mi sentivo di raccontare, che mi richiamavano, erano quelle. Aggiungo che anche il personaggio del romanzo al quale sto lavorando è accerchiato dalla solitudine. Forse potrei dire con una battuta che la compagnia non fa letteratura. Più seriamente mi sembra che sia estremamente difficile ricondurre quello che si scrive a una dimensione di razionalità. O almeno è difficile per me. Non lo so fare. Credo che con una dimensione di razionalità si possa discutere del linguaggio, dello stile, della costruzione del romanzo. Più difficile risulta ragionare sulle motivazioni che riguardano la scelta dei personaggi, anche se, ripeto, non siamo noi a scegliere i personaggi ma loro a scegliere noi. Quando comincio a scrivere una storia non so mai com’è che andrà a finire. A volte cerco di darmi un ordine, una sequenza, magari mi appunto un finale. Poi puntualmente salta l’ordine, la sequenza, e il finale cambia continuamente. Se ci penso mi accorgo che non c’è mai un vero finale. Avrei potuto continuare a far parlare Federico o l’Esiliato all’infinito. Ecco, mi piacerebbe scrivere una storia che non finisce mai e che quindi non puoi pubblicare mai.
Lei mi chiede delle influenze. Sinceramente ho letto un po’ cose di ogni genere, saggistica, narrativa, poesia, anche in modo disordinato, e mi riesce un po’ difficile catalogare.
Prima di scrivere Federico ho letto moltissime cose su di lui. Per un anno ho letto e basta. Per un altro anno ho cercato di dimenticare quello che avevo letto perché questo personaggio in realtà non voleva fare altro che dimenticare.
La stessa cosa mi è accaduta con l’Esiliato. Ho letto molto di e su Lorenzo il Magnifico, sulla Firenze dei Medici, ho letto anche Marsilo Ficino, ho letto anche Ermete Trismegisto, e queste letture mi hanno anche divertito. Poi ho cominciato a scrivere. E’ un libro che ho scritto con molta pacatezza, al contrario di Federico e di Stralune. E forse dallo stile si vede, non so.
Quello che posso dire, comunque, è che faccio molto lavoro sul piano del linguaggio.
Posso rimanere su una frase anche per una settimana. Ecco, se dovessi trovare una teoria o un maestro per questo mi riferirei a Flaubert che diceva in una della sue lettere a Louise Colette: una frase di prosa dev’essere come un bel verso: altrettanto ritmata, altrettanto sonora.
Così io rimango su una frase finche non “ suona” come dico io.
Qualcuno ha detto che c’è molta musicalità nella mia prosa, che si tratta di una prosa poetica. Credo che sia vero. Al cinquanta per cento è istinto, al cinquanta per cento è ricerca.
Insomma, fino a questo momento sono stato attratto da questo tipo di scrittura. In seguito non so.
D’altra parte, se devi scrivere devi farlo in un modo che ti piace. Altrimenti fai altro. Non è obbligatorio scrivere un romanzo. Poi, spesso, scrivere come ti piace costa fatica. La forma costa cara, diceva Paul Valery. Certe sere te ne vai a letto come se avessi fatto otto ore di zappa. Ma dove c’è gusto non c’è perdenza, si dice.
D.- Lasciandoci alle spalle ciò che ha già fatto, scritto e raccontato, e volgendo lo sguardo al futuro ci dica se ha già qualcosa in cantiere, e se fosse possibile, di cosa si tratta.
R.- Mi scuso per la risposta che sto per dare e che comunque cerco di giustificare. Dunque: sono stupidamente superstizioso. Se un gatto nero mi attraversa la strada, cambio strada. Per scaramanzia non dico mai quello che sto scrivendo. Quindi non dirò l’argomento ma soltanto che sto lavorando a due scritture parallelamente, perché una delle due mi serve per staccarmi da un personaggio molto forte. Scrivo con un metodo da artigiano. Due cartelle a sera, anche perché il mestiere che faccio non mi lascia molto tempo. Una è quasi finita e la farò raffreddare per un po’, poi la riprenderò per vedere com’è venuta.
Un’altra è ancora a metà. E’ più complessa, sia psicologicamente sia come testo. Ma non ho fretta.
Basta la fretta con cui inevitabilmente si scrive per i giornali. Per quanto riguarda la scrittura narrativa sono stato sempre convinto che ci sia bisogno di lentezza, di sedimentazione delle storie e delle parole.
Maria Assunta Russo
Condividi :